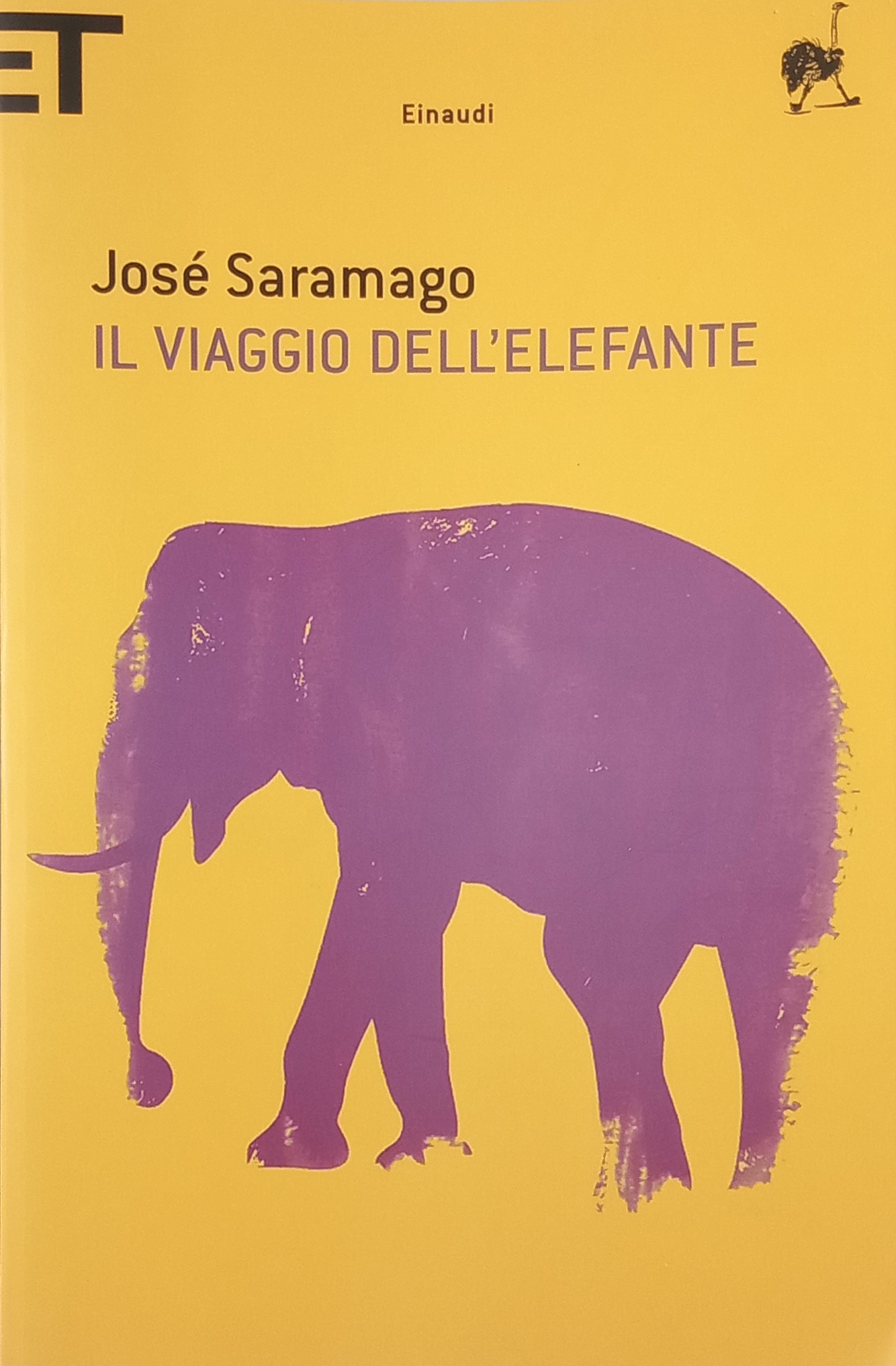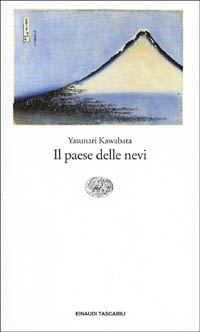
Yasunari Kawabata, Il paese delle nevi
A inizio lettura ho creduto che fosse necessario qualche accenno alla cultura giapponese, per cominciare a collocare narrazione, personaggi, atmosfere. Illusa! Come se per avvicinarsi a qualcosa di così lontano, e così diverso, e soprattutto così complesso, potesse bastare qualche pennellata di colore qua e là...
A inizio lettura ho creduto che fosse necessario qualche accenno alla cultura giapponese, per cominciare a collocare narrazione, personaggi, atmosfere. Illusa! Come se per avvicinarsi a qualcosa di così lontano, e così diverso, e soprattutto così complesso, potesse bastare qualche pennellata di colore qua e là...
No, niente da fare: per dire la mia sul significato dell'uso dei colori, per azzardarmi a interpretare gli stati d'animo inespressi e quelli che a volte prorompono, per tentare un'interpretazione quale che sia, ho strumenti inadatti, spuntati, rozzi. Mi muoverei come il famoso elefante (...) in cristalleria, farei uno scempio di quanto di delicato e sospeso c'è in questo romanzo - ed è molto.
Candidamente mi aspettavo che alla fine i nodi si sarebbero sciolti, che come in un giallo tascabile il Narratore ci avrebbe rivelato di che natura fosse il legame tra Komako, Yoko e Yukio, se davvero la giovane fosse pazza e perché, o se invece la pazza –per amore?- non fosse piuttosto Komako stessa, e poi che cosa sia realmente questa pretesa pazzia… Invece, niente. Yukio è morto, morta è la maestra di piano, e mai Komako è stata al cimitero a visitarli. E’ grave, questo? E’ ammissibile, nel Giappone del secolo scorso? Morirà Yoko, e qualcuno sembrerà soffrire…
Bianca la neve, bianco il colore del lutto, bianchi i freschi tessuti estivi. Rossi il fuoco, l’acero in autunno, l’orlo del sottokimono di Komako: qualcosa a che fare con il colore nuziale? Chi sa.
La fisicità di Komako poi è così diversa da quella che impariamo a immaginare osservando le immagini di geisha, si tratti di antiche incisioni o moderne fotografie. La si pensa donna immobile, raffinata, dall’estetica impeccabile; invece Komako fuma, beve molto, spesso si aggrappa a un braccio o cade malamente addosso a Shimamura, gli si presenta in camera di notte, ride e piange in maniera sguaiata. Di che si tratta? Umori volubili normali in una ragazza di vent’anni… o forse è altro? Forse è errata l’immagine di geisha costruita fino ad or, ed è più corretta questa? Giovane donna sola, con un traballante progetto di vita; donna a tratti seducente, invitante, ad altri in fuga, capace di atti sensuali come un rapido morso, e di scene isteriche e apparentemente insensate. Cosa va attribuito al suo personaggio, cos’altro semplicemente al ‘tipo’?
E il treno? Quanti treni nella letteratura giapponese. Treni che partono verso il cielo, treni che deragliano, treni nel silenzio e treni nel chiasso della metropoli, treni che attraversano gallerie e fondali marini, treni antiquati e treni-proiettle… E questo? Il treno che porta Shimamura al Paese delle nevi, e poi inesorabilmente lo riporta al suo Altrove, che treno sarà? A quali altri treni vorrà alludere? Quali treni avrà generato a sua volta?
E il caldo, il freddo. E la presenza e l’assenza del sesso… e gli insetti, questo continuo ronzio di tarme, falene, bachi, un fastidio incessante, una continua agonia… perché?
Basta con le domande. La lettura di questo romanzo ne ha sollevate moltissime, ed è un suo grande merito. Kawabata Yasunari, affascinato dall’Occidente, ci regala un ritratto delicato e profondissimo del suo Paese. Senza aver affrontato la lettura agostana del suo Paese delle nevi, difficilmente saprei ora che esistono gli onsen (dove è preferibile non presentarsi se si è tatuati) e le relative onsen-geisha, con caratteristiche diverse dalle geiko tradizionali. Non saprei cos’è un kotatsu, né che esiste una carpa il cui nome significa rosso-bianco (carpa koi della varietà Kohaku). Non avrei idea di come si indossa un kimono, e che esista anche un sottokimono più facile da lavare, e che si chiami (ma non sempre) juban e che possa essere portato da donne e da uomini, e che nelle donne il suo colore possa indicare lo stato di maiko (se rosso) o di geiko (se bianco); e che il passaggio da uno stato all’altro abbia anch’esso un nome, mizuage… Non saprei nemmeno del rapporto tra Yasunari Kawabata e Mishima Yukio, né del suicidio di entrambi.
Ma da raccogliere frammenti di una cultura, a sbilanciarsi nell’interpretazione di un romanzo breve e complesso come il Paese delle nevi, ce ne passa… perciò mi fermo qui, tanto più che è finita ora anche la Storia di erbe fluttuanti (http://tinyurl.com/3d4mdmg) che scorreva muto in sottofondo, ad arricchire di immagini questo paese di fantasia che rimane tuttora ai miei occhi il Giappone.
Approfondimenti in:
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3172847
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173328
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173714
Approfondimenti in:
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3172847
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173328
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173714