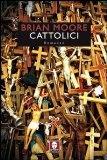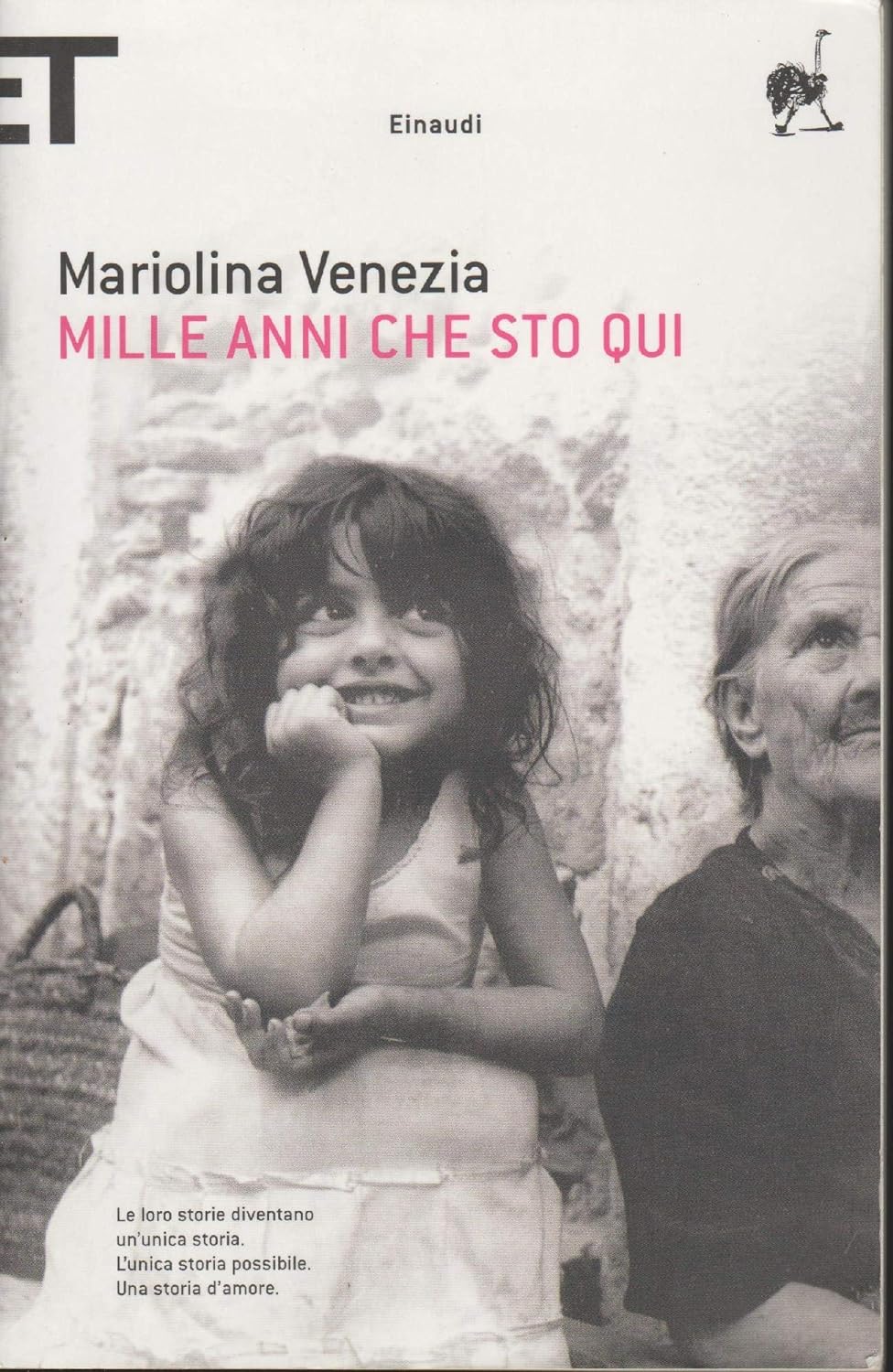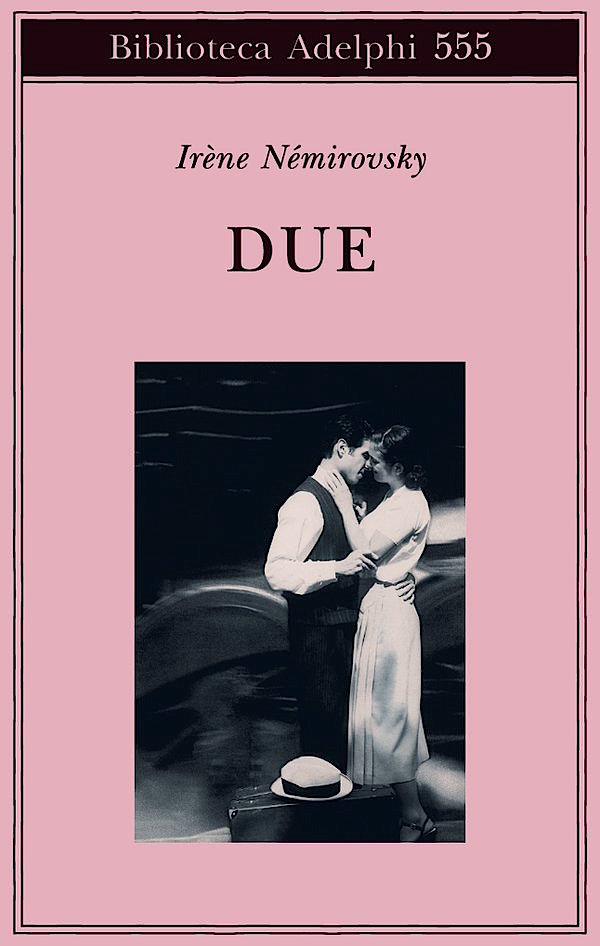Questo signore nella foto si chiama Marcello.
Si chiamava, perché è morto due giorni fa. Io l'ho saputo oggi.
Marcello Verdica.
Marcello Verdica Costantini, dicono i giornali; e io, questo secondo cognome, lo imparo ora.
Il suo nome e la sua foto erano sui giornali di oggi perché Marcello
si è suicidato, e non in un modo qualunque: ha commesso un
suicidio assistito.
Marcello è una di quelle persone che ci sono da sempre, amico dei miei genitori da che ho memoria. Era a casa sua che passavo tanti sabati pomeriggio, i grandi a giocare a carte, a parlare, chi lo sa; io e mio fratello in giardino con i gatti, o a fare le capriole sulla sedia a dondolo di bambù, oppure se fuori era brutto a osservare la collezione di pietre in salotto, e gli strani quadri in giro per casa, qualche volta perfino ammessi accanto al garage, nel Laboratorio-dove-si-sviluppano-le-foto.
Marcello. Marcello e Sara.

Non bisogna mica pensare, in realtà, a questo signore qui sopra. Quel Marcello là ha sì e no quarant'anni, trentacinque piuttosto; e la barba sì, ma scura. Un giorno, con i miei genitori, decidono di comprare una barca. Una specie di vasca da bagno in vetroresina, con un motorino fuoribordo da quattro cavalli. Ci salgono, tutti e quattro, prendono il largo. Non sono andati molto lontano perché la vasca da bagno, con i quattro giovani adulti scapestrati, è affondata. Non paghi, hanno comperato un gommone, sempre in comproprietà. Motore da venti cavalli, un Ducati.
Io non so se le cose siano andate proprio come racconto, è passato tanto tempo, io ero bambina e capivo quel che capivo; ma me le ricordo così. Ricordo per esempio che le cose, loro, i grandi -i grandi che conoscevo io- le facevano sul serio. C'era il gommone, e quindi c'erano la Gommonata e i Gommonauti. Era un mondo di favole.
Sono gli anni Settanta: gli uomini hanno quasi tutti i baffi e le basette, qualche volta i capelli lunghi; le donne i capelli li hanno lunghissimi o cortissimi, e quando vanno al mare dimenticano a casa il reggiseno - e le nonne si indignano e dicono "Quella là....".
Dai ricordi riemergono poi nomi di cose e persone. Lidio e la Pro Loco. Giancarlo e i Liberali, e la macchina da scrivere con i caratteri corsivi. La Dora, Mario, i referendum... L'
AIED, qualsiasi cosa sia, quante volte l'ho sentita nominare! "Mamma ma perché loro non hanno bambini? "Perché non ne vogliono". Mistero... Capivo vagamente che l'AIED in qualche modo c'entrava; ma come, chi lo sa.
Il gommone successivo, Marcello e Sara l'hanno comprato da soli. Era grandissimo, e ci hanno fatto il giro d'Italia e hanno pubblicato le foto su un giornale. E' il ricordo di una bambina, magari sono andati "solo" fino a Ancona. Forse però sono arrivati fino in Grecia; e se ci sono arrivati, di sicuro ci si sono trovati bene. E ci sono andati di nuovo. E poi una volta hanno deciso di
restare là, e allora niente più gatti nel giardino della casa, niente più casa, niente più quadri né foto, né Marcello, né Sara.
Li ho rivisti tempo dopo, Sara era su una carrozzella, avvolta in sciarpe e piumoni, troppi per una stagione tiepida. Poi, lei non l'ho vista più.
Oggi so che non vedrò più nemmeno Marcello; perché ha fatto un'altra delle sue scelte decise, senza ritorno e senza esitazioni. E ora tutti i ricordi si ricompongono in un disegno sensato.
Marcello era ammalato. Aveva un tumore al cavo orale per il quale era stato operato una volta, forse due. L'operazione successiva l'avrebbe lasciato incapace di bere, di mangiare, di parlare, senza peraltro garantire nulla sulle probabilità di continuare a vivere. La sua prospettiva era questa: un periodo forse breve, forse lungo o magari lunghissimo (minuto, dopo minuto, dopo minuto...) di vita, senza poter vivere. Unica certezza la sofferenza fisica, che già c'era; e certamente anche emotiva. Terapia del dolore, dunque: ma anche quella, lasciava intontiti, assenti, non permetteva di vivere. Quindi, ancora una volta, la scelta di autodeterminarsi.
Forse dovrei chiamarlo così, questo post: Autodeterminazione. Forse lo farò.
Ma andrebbero bene anche Coraggio, Coerenza, Diritti...
Scegliere, e permettere agli altri di scegliere per se stessi: questa è la lezione di Marcello.

Marcello si è rivolto a un'associazione in Svizzera, perché in Italia voler morire è reato. Non si può, non si deve. In Italia il calice, per quanto amaro, va bevuto fino in fondo. E' morto in esilio, Marcello, in compagnia di una persona coraggiosa che l'ha sostenuto, l'ha accompagnato fin là, e ha atteso con lui. Non so se questa persona abbia voglia di essere nominata, perciò non lo faccio. Ma l'associazione si chiama
Dignitas, e si trova
qui.