parole scritte o dette, parole in versi o in prosa, parole per convincere o per ricordare, per confidarsi, redimersi o mentire: questo spazio è dedicato alla lettura, alla scrittura, e alla vita.
Visualizzazione post con etichetta cinema. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta cinema. Mostra tutti i post
sabato 27 ottobre 2012
lunedì 22 agosto 2011
Giappone
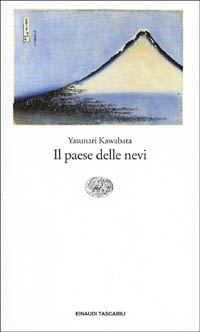
Yasunari Kawabata, Il paese delle nevi
A inizio lettura ho creduto che fosse necessario qualche accenno alla cultura giapponese, per cominciare a collocare narrazione, personaggi, atmosfere. Illusa! Come se per avvicinarsi a qualcosa di così lontano, e così diverso, e soprattutto così complesso, potesse bastare qualche pennellata di colore qua e là...
A inizio lettura ho creduto che fosse necessario qualche accenno alla cultura giapponese, per cominciare a collocare narrazione, personaggi, atmosfere. Illusa! Come se per avvicinarsi a qualcosa di così lontano, e così diverso, e soprattutto così complesso, potesse bastare qualche pennellata di colore qua e là...
No, niente da fare: per dire la mia sul significato dell'uso dei colori, per azzardarmi a interpretare gli stati d'animo inespressi e quelli che a volte prorompono, per tentare un'interpretazione quale che sia, ho strumenti inadatti, spuntati, rozzi. Mi muoverei come il famoso elefante (...) in cristalleria, farei uno scempio di quanto di delicato e sospeso c'è in questo romanzo - ed è molto.
Candidamente mi aspettavo che alla fine i nodi si sarebbero sciolti, che come in un giallo tascabile il Narratore ci avrebbe rivelato di che natura fosse il legame tra Komako, Yoko e Yukio, se davvero la giovane fosse pazza e perché, o se invece la pazza –per amore?- non fosse piuttosto Komako stessa, e poi che cosa sia realmente questa pretesa pazzia… Invece, niente. Yukio è morto, morta è la maestra di piano, e mai Komako è stata al cimitero a visitarli. E’ grave, questo? E’ ammissibile, nel Giappone del secolo scorso? Morirà Yoko, e qualcuno sembrerà soffrire…
Bianca la neve, bianco il colore del lutto, bianchi i freschi tessuti estivi. Rossi il fuoco, l’acero in autunno, l’orlo del sottokimono di Komako: qualcosa a che fare con il colore nuziale? Chi sa.
La fisicità di Komako poi è così diversa da quella che impariamo a immaginare osservando le immagini di geisha, si tratti di antiche incisioni o moderne fotografie. La si pensa donna immobile, raffinata, dall’estetica impeccabile; invece Komako fuma, beve molto, spesso si aggrappa a un braccio o cade malamente addosso a Shimamura, gli si presenta in camera di notte, ride e piange in maniera sguaiata. Di che si tratta? Umori volubili normali in una ragazza di vent’anni… o forse è altro? Forse è errata l’immagine di geisha costruita fino ad or, ed è più corretta questa? Giovane donna sola, con un traballante progetto di vita; donna a tratti seducente, invitante, ad altri in fuga, capace di atti sensuali come un rapido morso, e di scene isteriche e apparentemente insensate. Cosa va attribuito al suo personaggio, cos’altro semplicemente al ‘tipo’?
E il treno? Quanti treni nella letteratura giapponese. Treni che partono verso il cielo, treni che deragliano, treni nel silenzio e treni nel chiasso della metropoli, treni che attraversano gallerie e fondali marini, treni antiquati e treni-proiettle… E questo? Il treno che porta Shimamura al Paese delle nevi, e poi inesorabilmente lo riporta al suo Altrove, che treno sarà? A quali altri treni vorrà alludere? Quali treni avrà generato a sua volta?
E il caldo, il freddo. E la presenza e l’assenza del sesso… e gli insetti, questo continuo ronzio di tarme, falene, bachi, un fastidio incessante, una continua agonia… perché?
Basta con le domande. La lettura di questo romanzo ne ha sollevate moltissime, ed è un suo grande merito. Kawabata Yasunari, affascinato dall’Occidente, ci regala un ritratto delicato e profondissimo del suo Paese. Senza aver affrontato la lettura agostana del suo Paese delle nevi, difficilmente saprei ora che esistono gli onsen (dove è preferibile non presentarsi se si è tatuati) e le relative onsen-geisha, con caratteristiche diverse dalle geiko tradizionali. Non saprei cos’è un kotatsu, né che esiste una carpa il cui nome significa rosso-bianco (carpa koi della varietà Kohaku). Non avrei idea di come si indossa un kimono, e che esista anche un sottokimono più facile da lavare, e che si chiami (ma non sempre) juban e che possa essere portato da donne e da uomini, e che nelle donne il suo colore possa indicare lo stato di maiko (se rosso) o di geiko (se bianco); e che il passaggio da uno stato all’altro abbia anch’esso un nome, mizuage… Non saprei nemmeno del rapporto tra Yasunari Kawabata e Mishima Yukio, né del suicidio di entrambi.
Ma da raccogliere frammenti di una cultura, a sbilanciarsi nell’interpretazione di un romanzo breve e complesso come il Paese delle nevi, ce ne passa… perciò mi fermo qui, tanto più che è finita ora anche la Storia di erbe fluttuanti (http://tinyurl.com/3d4mdmg) che scorreva muto in sottofondo, ad arricchire di immagini questo paese di fantasia che rimane tuttora ai miei occhi il Giappone.
Approfondimenti in:
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3172847
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173328
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173714
Approfondimenti in:
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3172847
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173328
http://www.anobii.com/forum_thread?topicId=3173714
martedì 24 maggio 2011
Bovarismo [bo-va-rì-smo]
s.m.: Inquietudine esistenziale provocata dal divario tra le condizioni di vita reali e le proprie aspirazioni [Il Sabatini Coletti - Dizionario della lingua italiana]
sm. [dal nome della protagonista del romanzo di Flaubert, Madame Bovary]. Indica la quotidiana insoddisfazione, il sogno dell'impossibile, lo scoramento della creatura umana languente in un mondo assai simile alla prigione, dove la vita si arresta sconfinando nel sogno di una libertà volta alle grandi cose. Il bovarismo è l'espressione di quell'ardente necessità di superare se stessi, forse sorretta dall'intuita, se pur non compresa, desolata realtà del proprio essere che impedisce di realizzarsi diversamente da come si è. L'analisi di questa contraddizione tra l'essere e la fantasia liberatrice ha trovato il suo giudice nel filosofo francese J. Gaultier de Laguionie, che ha ravvisato nel personaggio di Flaubert i sintomi di una vera e propria malattia dello spirito. [Sapere.it]
s.m. LETTER Atteggiamento di chi si ritiene diverso da quello che è, costruendosi un mondo immaginario nel quale proietta desideri e frustazioni che nascono dall'insoddisfazione per la propria condizione reale [Aldo Gabrielli - Grande Dizionario italiano]
In psicologia (dalla protagonista del romanzo Madame Bovary di G. Flaubert), tendenza a costruirsi una personalità fittizia e a sostenere un ruolo non corrispondente alla propria condizione sociale. [Treccani.it]
Quello al bovarismo (malattia testualmente contagiosa) è inoltre il sesto dei dieci diritti del lettore secondo Daniel Pennac: "E’ questo, a grandi linee, il “bovarismo”, la soddisfazione immediata ed esclusiva delle nostre sensazioni: l’immaginazione che si dilata, i nervi che vibrano, il cuore che si accende, l’adrenalina che sprizza, l’dentificazione che diventa totale e il cervello che prende (momentanemente) le lucciole del quotidiano per le lanterne dell’universo romanzesco… E’ il nostro primo stato di lettori."
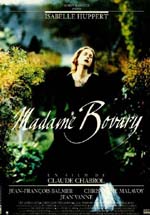 E pure, e pure. Forse merita maggiore simpatia e indulgenza quell'Emma Bovary, non così incapace di cambiare ciò che non la soddisfa, coraggiosa e sfrontata quando va alla ricerca di un piacere proibito, negato, irraggiungibile e per questo assolutamente delizioso.
E pure, e pure. Forse merita maggiore simpatia e indulgenza quell'Emma Bovary, non così incapace di cambiare ciò che non la soddisfa, coraggiosa e sfrontata quando va alla ricerca di un piacere proibito, negato, irraggiungibile e per questo assolutamente delizioso.Bovarista non è piuttosto suo marito? Quel dottor Bovary incapace di vedere la realtà, tanto meno di modificarla. Meno reale di Emma, meno drammatico, meno concreto.
E si, allora: Emma, c'est moi. E ben venga la voracità letteraria, ben vengano i sogni ad occhi aperti, lo sguardo lucido di chi vive, e intanto vede scorrere in trasparenza le immagini del romanzo che lo aspetta fedele la sera, sul comodino accanto al letto. Ben venga il desiderio di storie. Ben venga infine la frenesia segreta di chi sorridendo cerca il modo per sottrarsi al chiasso e ritirarsi in un angolo tranquillo. A leggere.
Perché "c'è sempre un desiderio che trascina, e una convenienza che trattiene".
Perché "c'è sempre un desiderio che trascina, e una convenienza che trattiene".
martedì 22 febbraio 2011
Il cielo sopra Berlino
Ti ricordi come una mattina il vivere, l'essere a nostra immagine da tanto tempo atteso, è uscito dalla savana, l'erba incollata alla fronte? E come la sua prima parola fosse un grido? Disse "ah!"; o "aaah!"; oppure "oh!". O fu semplicemente un gemito. Di quest'uomo abbiamo potuto ridere, finalmente: per la prima volta. E dal suo grido, e dal modo con cui chiamava i suoi successori, abbiamo imparato a parlare.
Una lunga storia: il sole, i lampi, il tuono su nel cielo, e sotto, sulla terra, i falò, i salti in aria, le danze circolari, i segni, la scrittura. Poi all'improvviso uno uscì dal cerchio: si mise a correre dritto, e intanto che correva sempre dritto (curvando, qualche volta, per baldanza) sembrò libero. E noi allora potemmo ridere con lui. Ma poi cambiò di colpo: si mise a correre a zig zag, le pietre volavano... Con la sua fuga iniziava un'altra storia: la storia delle guerre, che ancora dura. Ma anche la prima, quella dell'erba, del sole, dei salti in aria e delle grida, dura ancora... [Damiel]
Stupore. Stupore grande è scoprire che questo bellissimo poetico film - con i monologhi lucidi e sospesi di Peter Handke, con le riflessioni sull'umanità e la sensazione, sulla finitezza e la realtà, con tante tante scene nella grande biblioteca, tra il brusio sommesso del pensiero di chi studia (quante volte l'ho sentito! quante volte sono entrata in biblioteca per goderne, per sapere di farne parte!)... - che questo film è stato girato per intero senza il sostegno della parola scritta. Senza un copione.
Quanta fiducia nell'umanità dell'uomo, nella sua capacità di creare e di essere. Quale bellissimo esempio di follia, nell'affidarsi a se stessi senza la pretesa di potersi bastare.
Poi c'è Berlino; e per le sale da ballo demolite, per le strade e le piazze e i muri che non esistono più, per i nuovi centri commerciali e l'anima antica, rimane ancora tanta curiosità.
Una lunga storia: il sole, i lampi, il tuono su nel cielo, e sotto, sulla terra, i falò, i salti in aria, le danze circolari, i segni, la scrittura. Poi all'improvviso uno uscì dal cerchio: si mise a correre dritto, e intanto che correva sempre dritto (curvando, qualche volta, per baldanza) sembrò libero. E noi allora potemmo ridere con lui. Ma poi cambiò di colpo: si mise a correre a zig zag, le pietre volavano... Con la sua fuga iniziava un'altra storia: la storia delle guerre, che ancora dura. Ma anche la prima, quella dell'erba, del sole, dei salti in aria e delle grida, dura ancora... [Damiel]
Stupore. Stupore grande è scoprire che questo bellissimo poetico film - con i monologhi lucidi e sospesi di Peter Handke, con le riflessioni sull'umanità e la sensazione, sulla finitezza e la realtà, con tante tante scene nella grande biblioteca, tra il brusio sommesso del pensiero di chi studia (quante volte l'ho sentito! quante volte sono entrata in biblioteca per goderne, per sapere di farne parte!)... - che questo film è stato girato per intero senza il sostegno della parola scritta. Senza un copione.
Quanta fiducia nell'umanità dell'uomo, nella sua capacità di creare e di essere. Quale bellissimo esempio di follia, nell'affidarsi a se stessi senza la pretesa di potersi bastare.
Poi c'è Berlino; e per le sale da ballo demolite, per le strade e le piazze e i muri che non esistono più, per i nuovi centri commerciali e l'anima antica, rimane ancora tanta curiosità.
venerdì 9 luglio 2010
Persona
Persona è la maschera.
Lo sapeva bene Bergman;
e ora lo ricordo meglio anche io.
Ricordo anche un tempo lontanissimo e perduto in cui, magari alle due di notte, la tv proponeva delle rassegne imperdibili, tutto Fellini, tutto Bergman, tutto Bunuel; e noi ancora ragazzi ci si cimentava con tutto Nanni Moretti in vhs nel salotto di casa... ma era tanto, tanto tempo fa.
mercoledì 8 luglio 2009
Fuoco!
In un paese, durante una processione, la statua della Madonna viene colpita e distrutta da ripetuti colpi di arma da fuoco. Mentre la gente fugge, intervengono le forze dell'ordine che circondano la casa da dove sono partiti gli spari. In una abitazione di poche stanze c'è il colpevole, Mario, che vive con la moglie e la piccola figlia, atterrita dalle detonazioni, mentre in un angolo giace il corpo inanimato di una persona. Mario passa le sue ore caricando le sue armi, o scrutando dalle finestre i movimenti della polizia e scaricando ogni tanto qualche colpo sulla piazza. Le continue e ripetute esortazioni di un carabiniere del paese sembrano non avere effetto sul giovane, che dà l'impressione di voler resistere a lungo. Alle prime luci della mattina però Mario si decide e, dopo aver ucciso la moglie, affida la bambina ai carabinieri e si arrende.
Questa, laconicamente, la trama di Fuoco! (anche qui) di Gian Vittorio Baldi, film del 1968 recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e pubblicato con un bel volume di apparato e commento. In un'intervista recente, inclusa nel dvd, Baldi lascia intendere che il film - realizzato in soli 14 giorni di riprese in presa diretta ma pensato, prima, per anni - parli appunto del 1968, dell'esplosione di energie represse e poi giunte a saturazione, della violenza contro la società e le sue istituzioni. Il regista interpreta dunque Fuoco! come film politico.
Certo gli indizi in questo senso sono molti. All'inizio dell'azione, un primo atto di violenza si è già compiuto, diretto verso la famiglia: Mario ha ucciso la suocera, che giace a terra senza poter essere compianta. Quindi, il protagonista si rivolge contro la chiesa, sparando alla statua della madonna in processione - scena esplicita al punto di perdere ogni aspetto simbolico, e da risultare puramente rappresentativa. Infine, ecco la violenza contro lo stato, che prende la forma del silenzio, della non-considerazione.
Ma Fuoco! è anche un film sulla tragedia della violenza, sulla necessità del male. Mario uccide sua moglie; perché lo faccia, non ci è spiegato mai. Le carezze nel sonno, denudarla per vederne un'ultima volta le forme (la schiena sensuale e arcaica, anche in una donna distrutta e abbrutita dalla paura, dalla violenza), avvolgerla in un sudario prima di sparare, non sono gesti d'amore? Mario non avrà forse ucciso per proteggere? E se affida la bambina ai carabinieri, non sarà perché non trova il coraggio di sparare anche a lei? Per un momento sembra sul punto di farlo; ma poi il pianto lo ferma, desiste. Mario è un uomo qualunque, né più buono né più violento di altri, solo per caso si trova all'interno di quell'appartamento e non fuori, tra gli altri. Come tutti, per necessità recita il ruolo che gli è toccato in sorte.
E forse è proprio la sua debolezza nel recitare fino in fondo la sua parte, forse è questa la sua colpa. Non spara alla bambina, non la salva; e decide di pagare il suo debito arrendendosi, e consegnandosi, nudo, al mondo.
L'abbiamo visto qualche sera fa, nel salotto di casa, insolitamente quieto.
Per caso, alla fine, alla tv stava cominciando Un giorno in pretura. Confronto disarmante. Era il 1953, e già veniva ucciso il neorealismo; scomparsi i personaggi, per lasciar posto alle macchiette. Niente più persone, entrano i personaggi, e poi titoli di testa, titoli di coda, nomi degli attori. Star! E germogliano le radici del qualunquismo italiano.
A passare da Fuoco! a Un giorno in pretura, sembrava di fare un percorso al contrario. E viene da chiedersi ora, se ci sia un'alternativa tra il lasciarsi scivolare in una vita in farsa, e l'attendere che la violenza esploda un'altra volta.
Questa, laconicamente, la trama di Fuoco! (anche qui) di Gian Vittorio Baldi, film del 1968 recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e pubblicato con un bel volume di apparato e commento. In un'intervista recente, inclusa nel dvd, Baldi lascia intendere che il film - realizzato in soli 14 giorni di riprese in presa diretta ma pensato, prima, per anni - parli appunto del 1968, dell'esplosione di energie represse e poi giunte a saturazione, della violenza contro la società e le sue istituzioni. Il regista interpreta dunque Fuoco! come film politico.
Certo gli indizi in questo senso sono molti. All'inizio dell'azione, un primo atto di violenza si è già compiuto, diretto verso la famiglia: Mario ha ucciso la suocera, che giace a terra senza poter essere compianta. Quindi, il protagonista si rivolge contro la chiesa, sparando alla statua della madonna in processione - scena esplicita al punto di perdere ogni aspetto simbolico, e da risultare puramente rappresentativa. Infine, ecco la violenza contro lo stato, che prende la forma del silenzio, della non-considerazione.
Ma Fuoco! è anche un film sulla tragedia della violenza, sulla necessità del male. Mario uccide sua moglie; perché lo faccia, non ci è spiegato mai. Le carezze nel sonno, denudarla per vederne un'ultima volta le forme (la schiena sensuale e arcaica, anche in una donna distrutta e abbrutita dalla paura, dalla violenza), avvolgerla in un sudario prima di sparare, non sono gesti d'amore? Mario non avrà forse ucciso per proteggere? E se affida la bambina ai carabinieri, non sarà perché non trova il coraggio di sparare anche a lei? Per un momento sembra sul punto di farlo; ma poi il pianto lo ferma, desiste. Mario è un uomo qualunque, né più buono né più violento di altri, solo per caso si trova all'interno di quell'appartamento e non fuori, tra gli altri. Come tutti, per necessità recita il ruolo che gli è toccato in sorte.
E forse è proprio la sua debolezza nel recitare fino in fondo la sua parte, forse è questa la sua colpa. Non spara alla bambina, non la salva; e decide di pagare il suo debito arrendendosi, e consegnandosi, nudo, al mondo.
L'abbiamo visto qualche sera fa, nel salotto di casa, insolitamente quieto.
Per caso, alla fine, alla tv stava cominciando Un giorno in pretura. Confronto disarmante. Era il 1953, e già veniva ucciso il neorealismo; scomparsi i personaggi, per lasciar posto alle macchiette. Niente più persone, entrano i personaggi, e poi titoli di testa, titoli di coda, nomi degli attori. Star! E germogliano le radici del qualunquismo italiano.
A passare da Fuoco! a Un giorno in pretura, sembrava di fare un percorso al contrario. E viene da chiedersi ora, se ci sia un'alternativa tra il lasciarsi scivolare in una vita in farsa, e l'attendere che la violenza esploda un'altra volta.
sabato 31 gennaio 2009
Espiazione
Atonement, film diretto da Joe Wright nel 2007, rivisita piuttosto fedelmente il romanzo di Ian McEwan (2001) da cui è tratto: uguale la suddivisione in quattro movimenti, identiche le ambientazioni, gli stessi personaggi. Ma film e romanzo raccontano davvero la stessa storia?
Entrambi ripercorrono le vicende della scrittrice Briony Tallis a partire da giorno in cui, appena adolescente, si rende conto della propria vocazione, fino al suo settantasettesimo compleanno.
Il primo movimento del film segue quasi pedissequamente il romanzo, se non perché alcuni personaggi rimangono più abbozzati. L'unica differenza rimarchevole è l'uso, da parte della giovane Tallis, di una rumorosa macchina da scrivere, che rende la creazione un atto meno segreto e intimo di quanto fosse nel romanzo: una trovata efficace dal punto di vista della sceneggiatura, ma -come si vedrà- anche un'anticipazione importante.
Nella seconda parte del film compare qualche variazione, soprattutto di ritmo, a prima vista ancora attribuibile ad esigenze di brevità dovute al mezzo cinematografico: il percorso di Robbie Turner verso il mare appare più rapido, e sono tagliate proprio le scene più drammatiche e spettacolari presenti nel testo letterario, primo tra tutti il bombardamento della colonna di militari e civili in fuga, da parte dell'aviazione tedesca. Inoltre, un'immagine fondamentale del romanzo -il cadavere di un bimbo dilaniato da una bomba, incubo che accompagnerà Robbie fino alla fine- è sostituita e come amplificata da quella di un'intera scolaresca sterminata; ma anche qui la scelta è di mostrare un'immagine pulita, dalla compostezza che la rende niente affatto realistica ma quasi astratta.
La terza parte, in cui Briony Tallis diciottenne studia per divenire infermiera, è ormai lontana dal seguire passo a passo il romanzo. Nonostante le vicende si svolgano quasi per intero in ospedale, e in buona parte alle prese con feriti di guerra, la presenza di sangue è ridotta all'indispensabile, e anche momenti drammatici come la morte del giovane panettiere francese sono resi senza insistenza sui dettagli, ma quasi con intensa liricità. Rimane presente la macchina da scrivere, rumorosa e del tutto improbabile in un dormitorio di ragazze tenute ad osservare in modo ferreo le regole più fantasiose, al solo fine di essere abituate all'obbedienza: così, se nel romanzo la penna è sostituita da un mozzicone di matita, nel film il ticchettio echeggia nella notte, e tiene il ritmo dell'esistenza della giovane scrittrice, che pure si trova là per espiare, appunto, la sua stessa esistenza.
A questo punto del film è emerso chiaramente anche un altro intervento di regia, ed è l'attenzione riservata all'acqua e ai suoi significati simbolici. La polarità tra il bagno di Cecilia nella fntana-fonte battesimale, di ristoro nella giornata di gran caldo, e la sete insopportabile di Robbie, separato da lei da cinque anni di carcere e di guerra, è sottolineata e rafforzata da numerosi dettagli del romanzo ai quali il regista lascia spazio, e alle diverse invenzioni che si concede. Il laghetto e la piscina di Villa Tallis sono mostrate, fin dall'inizio, sotto ogni angolazione, così da poter essere rimpianti per tutto il resto della storia, e Wright insiste sull'episodio parallelo al bagno della sorella, narrato in flashback, di Briony bambina che si tuffa per essere salvata. In Francia, il cammino di Robbie prende avvio lungo un canale, la cui quiete ordinaria dovrà a sua volta essere rimpianta nelle scene a seguire. Briony si lava le mani all'ospedale: nel film, non più per richiesta pressante della caposala, ma per una sua necessità di pulizia e di purificazione. E per acqua viene anche la morte dei due amanti: Robbie per setticemia, prosciugato dalla sete; Cecilia -e questa è invenzione del regista- travolta dall'acqua di una tubatura esplosa, a causa di una bomba. Robbie dunque ucciso dalle privazioni, Cecilia annegata nella sua stessa passione.
E si viene così all'epilogo, breve in entrambi i casi, e risolutivo. Briony Tallis, divenuta scrittrice di successo, compie 77 anni e ha ricevuto da poco la notizia di essere affetta da una malattia degenerativa che la priverà della capacità di parlare, poi di capire, quindi di ricordare. Nelle due versioni compare l'incontro tardivo di Briony con Cecilia e Robbie, sopravvissuti alla guerra e finalmente riuniti; e in entrambe il romanzo non è ancora stato pubblicato. Ma a questo punto, romanzo e film si allontanano irreparabilmente.
Il romanzo di McEwan è anche una riflessione sulla scrittura, e il film deve arrestarsi davanti al gioco di rispecchiamento. E se nel libro la pubblicazione-redenzione non è avvenuta per timore di un'innaffrontabile causa da parte del troppo ricco e troppo potente Paul Marshall o della sua giovanile e aggressiva moglie Lola, nel film tutto è dovuto a un dubbio personale della scrittrice.
Nel film, dalla scena finale scompaiono la villa divenuta resort, la famiglia numerosa, i tanti presenti e i troppi assenti; la telecamera si svela nell'allestimento di un'intervista televisiva, con tanto di interruzione su richiesta della scrittrice, che chiede una pausa per riflettere, per ricordare finché può.
Il romanzo si conclude con una nota di mestizia: "Mi piace pensare che non sia debolezza né desiderio di fuga, ma un ultimo gesto di cortesia, una presa di posizione contro la dimenticanza e l'angoscia, permettere ai miei amanti di sopravvivere e vederli uniti alla fine. Ho regalato loro la felicità, ma non sono stata tanto opportunista da consentire che mi perdonassero, non proprio, non ancora. E se avessi il potere di evocare la loro presenza alla mia festa di compleanno... Robbie e Cecilia, ancora vivi, ancora innamorati, seduti accanto in biblioteca, a sorridere delle Disavventure di Arabella? Non è escluso. Ora basta però, devo dormire." La scrittrice indulge nella propria onnipotenza, è giunta alla fine della vita ma lascia ancora una porta aperta alla creazione letteraria, vanificando così la propria espiazione.
Entrambi ripercorrono le vicende della scrittrice Briony Tallis a partire da giorno in cui, appena adolescente, si rende conto della propria vocazione, fino al suo settantasettesimo compleanno.
Il primo movimento del film segue quasi pedissequamente il romanzo, se non perché alcuni personaggi rimangono più abbozzati. L'unica differenza rimarchevole è l'uso, da parte della giovane Tallis, di una rumorosa macchina da scrivere, che rende la creazione un atto meno segreto e intimo di quanto fosse nel romanzo: una trovata efficace dal punto di vista della sceneggiatura, ma -come si vedrà- anche un'anticipazione importante.
Nella seconda parte del film compare qualche variazione, soprattutto di ritmo, a prima vista ancora attribuibile ad esigenze di brevità dovute al mezzo cinematografico: il percorso di Robbie Turner verso il mare appare più rapido, e sono tagliate proprio le scene più drammatiche e spettacolari presenti nel testo letterario, primo tra tutti il bombardamento della colonna di militari e civili in fuga, da parte dell'aviazione tedesca. Inoltre, un'immagine fondamentale del romanzo -il cadavere di un bimbo dilaniato da una bomba, incubo che accompagnerà Robbie fino alla fine- è sostituita e come amplificata da quella di un'intera scolaresca sterminata; ma anche qui la scelta è di mostrare un'immagine pulita, dalla compostezza che la rende niente affatto realistica ma quasi astratta.
La terza parte, in cui Briony Tallis diciottenne studia per divenire infermiera, è ormai lontana dal seguire passo a passo il romanzo. Nonostante le vicende si svolgano quasi per intero in ospedale, e in buona parte alle prese con feriti di guerra, la presenza di sangue è ridotta all'indispensabile, e anche momenti drammatici come la morte del giovane panettiere francese sono resi senza insistenza sui dettagli, ma quasi con intensa liricità. Rimane presente la macchina da scrivere, rumorosa e del tutto improbabile in un dormitorio di ragazze tenute ad osservare in modo ferreo le regole più fantasiose, al solo fine di essere abituate all'obbedienza: così, se nel romanzo la penna è sostituita da un mozzicone di matita, nel film il ticchettio echeggia nella notte, e tiene il ritmo dell'esistenza della giovane scrittrice, che pure si trova là per espiare, appunto, la sua stessa esistenza.
A questo punto del film è emerso chiaramente anche un altro intervento di regia, ed è l'attenzione riservata all'acqua e ai suoi significati simbolici. La polarità tra il bagno di Cecilia nella fntana-fonte battesimale, di ristoro nella giornata di gran caldo, e la sete insopportabile di Robbie, separato da lei da cinque anni di carcere e di guerra, è sottolineata e rafforzata da numerosi dettagli del romanzo ai quali il regista lascia spazio, e alle diverse invenzioni che si concede. Il laghetto e la piscina di Villa Tallis sono mostrate, fin dall'inizio, sotto ogni angolazione, così da poter essere rimpianti per tutto il resto della storia, e Wright insiste sull'episodio parallelo al bagno della sorella, narrato in flashback, di Briony bambina che si tuffa per essere salvata. In Francia, il cammino di Robbie prende avvio lungo un canale, la cui quiete ordinaria dovrà a sua volta essere rimpianta nelle scene a seguire. Briony si lava le mani all'ospedale: nel film, non più per richiesta pressante della caposala, ma per una sua necessità di pulizia e di purificazione. E per acqua viene anche la morte dei due amanti: Robbie per setticemia, prosciugato dalla sete; Cecilia -e questa è invenzione del regista- travolta dall'acqua di una tubatura esplosa, a causa di una bomba. Robbie dunque ucciso dalle privazioni, Cecilia annegata nella sua stessa passione.
E si viene così all'epilogo, breve in entrambi i casi, e risolutivo. Briony Tallis, divenuta scrittrice di successo, compie 77 anni e ha ricevuto da poco la notizia di essere affetta da una malattia degenerativa che la priverà della capacità di parlare, poi di capire, quindi di ricordare. Nelle due versioni compare l'incontro tardivo di Briony con Cecilia e Robbie, sopravvissuti alla guerra e finalmente riuniti; e in entrambe il romanzo non è ancora stato pubblicato. Ma a questo punto, romanzo e film si allontanano irreparabilmente.
Il romanzo di McEwan è anche una riflessione sulla scrittura, e il film deve arrestarsi davanti al gioco di rispecchiamento. E se nel libro la pubblicazione-redenzione non è avvenuta per timore di un'innaffrontabile causa da parte del troppo ricco e troppo potente Paul Marshall o della sua giovanile e aggressiva moglie Lola, nel film tutto è dovuto a un dubbio personale della scrittrice.
Nel film, dalla scena finale scompaiono la villa divenuta resort, la famiglia numerosa, i tanti presenti e i troppi assenti; la telecamera si svela nell'allestimento di un'intervista televisiva, con tanto di interruzione su richiesta della scrittrice, che chiede una pausa per riflettere, per ricordare finché può.
Il romanzo si conclude con una nota di mestizia: "Mi piace pensare che non sia debolezza né desiderio di fuga, ma un ultimo gesto di cortesia, una presa di posizione contro la dimenticanza e l'angoscia, permettere ai miei amanti di sopravvivere e vederli uniti alla fine. Ho regalato loro la felicità, ma non sono stata tanto opportunista da consentire che mi perdonassero, non proprio, non ancora. E se avessi il potere di evocare la loro presenza alla mia festa di compleanno... Robbie e Cecilia, ancora vivi, ancora innamorati, seduti accanto in biblioteca, a sorridere delle Disavventure di Arabella? Non è escluso. Ora basta però, devo dormire." La scrittrice indulge nella propria onnipotenza, è giunta alla fine della vita ma lascia ancora una porta aperta alla creazione letteraria, vanificando così la propria espiazione.
E il film? Si ferma poco prima, al regalo della felicità. Uguale l'onnipotenza, mentre il dubbio, il "Non è escluso" è lasciato agli occhi di Vanessa Redgrave; e per descrivere questo, le parole non sono sufficienti.
Iscriviti a:
Post (Atom)

